PREFAZIONE
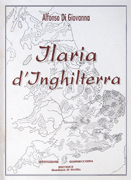 Alfonso Di Giovanna é più vecchio di me di una decina d’anni. Non posso quindi dire che siamo stati amici d’infanzia. In paese tutti, e quindi anch’io, conoscevano il suo nome, ma il rapporto tra noi é nato più tardi, quando entrambi eravamo adulti.
Alfonso Di Giovanna é più vecchio di me di una decina d’anni. Non posso quindi dire che siamo stati amici d’infanzia. In paese tutti, e quindi anch’io, conoscevano il suo nome, ma il rapporto tra noi é nato più tardi, quando entrambi eravamo adulti.
Non ricordo in quale città d’Italia lavoravo quando cominciai a leggere sulla stampa dei conflitti tra Alfonso, giovane e impegnato sacerdote, e la Gerarchia.
Ricordo però che la mia prima reazione, leggendo le notizie, fu quella di cercarlo per parlare assieme e “impadronirmi” in qualche modo di lui.
Alfonso rispose prontamente al mio appello, quasi lo aspettasse, e nacque tra noi un’amicizia che – agli inizi non lo sapevamo certo – durerà per la vita.
Svolgevo allora, come del resto ancora oggi, un’attività che mi portava a girare per l’Italia, perciò a recarmi anche nelle città dove Alfonso via via, successivamente alla rottura con la Chiesa istituzionale, stabiliva la residenza, e ogni volta che ci incontravamo inseguivamo per ore i nostri fantasmi, costituiti il più delle volte dalla storia locale, quella delle nostre radici ma spesso anche da temi più generali riguardanti la condizione umana. Rita, che era già sua compagna, ascoltava, qua e là intervenendo, sempre incuriosita, talora divertita, mentre magari apparecchiava un frugale boccone per tutti e tre. E fu così per anni! Fu quindi naturale che fossi testimone alle loro nozze, celebrate in comune a Torino, dove Alfonso si era “rifugiato” e aveva trovato un umile lavoro manuale.
Ricordo bene quella cerimonia di nozze per uno di quei particolari senza importanza, che però restano impressi e danno colorito ai racconti. Mi recai di corsa in comune, provenendo da Milano, già in ritardo sull’ora dell’appuntamento e senza il tempo di lucidare le mie scarpe, che erano sporche. Ogni tanto, sfogliando l’album, rivedo la foto scattata nell’occasione e le mie scarpe sporche, ma al tempo stesso ricordo la mia affettuosa partecipazione alla festa di Alfonso e di Rita.
I nostri rapporti ebbero un lieve declino quando Alfonso fu sindaco: mi pareva che le responsabilità della posizione gli facessero perdere interesse per la nostra amicizia, e quindi lo cercavo di meno. Ma forse la mia era un’impressione sbagliata, sia come sia, il rapporto riprese vigore quando lui lasciò Palazzo dell’Arpa.
Ho voluto rievocare, con estrema sintesi, la nostra amicizia, perché non posso escludere che essa mi porti a valutare con occhi eccessivamente benevoli le qualità di Alfonso Di Giovanna scrittore. Tuttavia mi sforzerò di essere, per quanto possibile, obiettivo.
Alfonso ha scritto pagine molto belle. Con “Anomale posizioni” ha raggiunto livelli degni di stare nell’antologia della letteratura italiana, degno come il miglior Navarro della Miraglia (quello de “La Nana” e non quello dei racconti, quasi tutti brutti e banali) e di Luigi Capuana. Direi che con i cinque racconti raccolti in “Anomale posizioni” Alfonso si avvicini alla potenza espressiva e letteraria del Verga, maggiore, solo perché l’ordito narrativo del grande catanese è più ricco e articolato.
Mi riesce più difficile un paragone con gli scrittori siciliani contemporanei, perché mi pare che ci sia in Alfonso un taglio verista che lo fa assimilare a quelli a cavallo tra ottocento e novecento.
Alfonso possiede la lingua, nella quale inserisce con sapienza efficaci sicilianismi. Mostra inoltre profonda conoscenza della vita. Vorrei aggiungere che quando serve, Sto arrivando! spalmare, qua e là, momenti di autentico erotismo, come del resto avviene negli scrittori veristi di buona razza.
Ma veniamo più in particolare a questo “Ilaria d’Inghilterra”, un libro che si legge con piacere e interesse perché le situazioni descritte toccano passaggi della nostra storia che abbiamo vissuto, più o meno intensamente, nell’ultimo mezzo secolo.
Ilaria é nata a Capovespro, paesino di Sicilia dal quale emigra per andare a fare l’operaia in Inghilterra. Si impone per le sue doti nella fabbrica dove lavora e finisce con lo sposare il “giovanottone inglese” che l’aveva accolta, assieme a lavoratrici siciliane, al momento dell’arrivo in Inghilterra. Una volta sposati, i due si trasferiscono in Sud Africa per aprirvi una succursale della casa madre. E qui il racconto si snoda attraverso le vicende pubbliche e private dei giovani sposi.
Tanti sono i protagonisti che si susseguono nella narrazione: non solo uomini, ma anche situazioni e concetti.
C’è innanzitutto il paese, più piccolo di Sambuca, ma che tanto gli somiglia: “arrampicato sul dorso di una collina” e pieno di comunisti; con quel calzolaio, Lorenzo Botta, comunista egli stesso, che sembra uscito da una delle nostre botteghe artigiane di alcuni decenni fa, quelle che Alfonso ed io abbiamo fatto in tempo a conoscere e frequentare; con quelle ragazze determinate ad uscire dalla miseria e dal degrado, cioè ad emanciparsi; con la benevola tolleranza verso le poche donne che, per vivere, vendono il corpo; con “quei vicoli e cortili angusti, remoti rispetto alla strada grande del paese”; con la “ventata di novità” succeduta alla fine della guerra; con i partiti che si ricostituiscono dopo il fascismo e la TV che più tardi irrompe “impetuosa”, con la crisi della natalità.
Poi c’è Ilaria, ribelle con giudizio di conoscenza e di sapere che legge i libri presi in prestito dalla biblioteca del “Partito”, che resiste al richiamo persuasivo della televisione; estranea alla fede religiosa per “partito preso”; “Cicerone” improvvisato delle compagne durante il lungo viaggio in treno verso il Sussex, dove si impegnerà nel lavoro, e, a sera, nell’apprendimento dell’inglese. C’è l’emigrazione, vista come epopea collettiva. Alfonso l’ha conosciuta bene, l’emigrazione, prima come parroco che perde pezzi del suo gregge, poi come responsabile di un «ufficio» destinato ad occuparsene. Ne parla perciò come uno che sa quel che dice.
C’è William, il giovanottone addetto alle pubbliche relazioni della ditta, che piano piano si invaghisce di Ilaria, fino a sposare la giovane e bella immigrata, dopo un avvicinamento d’amore delicatamente raccontato.
C’è la folla in paese che accoglie Ilaria tornata per un periodo di ferie, col calzolaio che accorre festoso tra gli altri. “Mancavano solo i petardi e la banda cittadina”.
C’è, sotteso in tutto il libro, il dibattito sulle verità religiose. Non essendo io interessato ad esse, mai nei nostri incontri ho stimolato Alfonso su questo tema, e quindi non conosco il suo pensiero in proposito. Ma mi pare che affiori il tormento del dubbio e al tempo stesso lo sforzo di “inventare” a proprio uso un personale rapporto con la Fede, un rapporto da «ateo-credente”, come lo aveva Ilaria.
C’è il Sud Africa, la tragedia dell’apartheid, la violenza ingiusta anche quando le lotte sono giuste, il sogno di una società parificata e libera, l’orrore del razzismo becero, l’odio che scatena gli istinti più profondi.
C’è l’insediamento di un nuovo complesso produttivo in un contesto percorso da tensioni estreme, da conflitti drammatici, con gravissimi problemi di convivenza.
C’è la descrizione di un bel rapporto coniugale, quello di William e Ilaria, come – mi permetto di suggerire – Alfonso l’ha per sé e per la sua Rita. Un rapporto felice, quanto possono esserlo le cose degli uomini.
C’è la forza devastante dei sommovimenti popolari originati da gravi ingiustizie (come, nel caso, l’assassinio di un leader politico amato) ma che, se non opportunamente guidati, sfociano in brutali e immotivate rappresaglie.
La tragedia finale – una bomba terrorista – colpisce Ilaria, ma non uccide la speranza, giacché Ilaria continuerà a vivere ed operare, sia pure in carrozzella.
Durante la degenza Ilaria si chiede chi mai l’abbia “spinta a buttarsi nella mischia” di una dura lotta politica a favore dei più deboli, dei discriminati; ma deve rispondersi che non poteva farci niente: la creta con cui era stata impastata non le consentiva di disinteressarsi al destino in terra degli uomini, suoi fratelli.
Mi viene in mente il racconto della vita di una giovane comunista di Caltagirone raccolto da Maria Attanasio e pubblicato nel 1999 dall’editore Sellerio. Concetta – questo è il nome della comunista – combatte, combatte, combatte e mai si arrese, perché quando suo padre la fece “di sicuro quella notte pensava alla bandiera rossa…”. Come forse il padre di Ilaria!
Rosario Amodeo
Le guerre si lasciano dietro lutti, disastri, dolori, conseguenze inimmaginabili: fame, malattie, disoccupazione.
A Capovespro, un paesino di circa duemila anime, arrampicato sul dorso di una collina, finita la guerra, l’ultima «grande guerra», si discuteva dalla mattina alla sera sul «che fare»?
Già: che fare? Si può piangere da mattina a sera sui morti ammazzati in Russia, in Cirenaica, nelle battaglie navali, a Massa Matruh?
– No, per Dio – gridava Botta quando sentiva i piagnistei sui disastri del passato – occorre, invece, darsi da fare, uscire da questi funerali.
Lorenzo Botta era il calzolaio del quartiere chiamato del «Vallone». Vallone per via di quell’ala che la collina, sulla quale si adagiavano le case, dispiegava verso il sud del paese.
Sosteneva Lorenzo che occorreva mettere una pietra sui disastri del passato. Fu così che dopo la prima guerra mondiale si superarono i guai. Almeno sino al ’23. Poco dopo ricominciarono col fascismo, sotto il quale, però, nonostante tutto, ci si dava da fare.
Nella bottega non si finiva mai di captare notizie: fresche e meno fresche, buone o cattive, ma di ogni genere. Una cassa di risonanza delle miserie umane.
Le notizie più interessanti riguardavano il lavoro, che a Capovespro non c’era: se si eccettuava qualche giorno durante la semina e, poi, al tempo del raccolto.
* * *
Ma fuori della Sicilia il lavoro c’è – infuriava Botta -: Se sangue di…, ve ne state fermi, qui, in questa «terra di tacco», morirete di fame. Voi, lo sapete: io tengo sempre le orecchie tese come una lepre, per cogliere tutto quello che sento o che mi riferiscono.
Stirava lo spago con la cera vergine, dopo averlo filato con la rocca, e riattaccava:
– A due passi da questo disgraziato paese, a San Luca, ogni giorno partono per il continente decine di giovani e meno giovani. Vanno a Brescia, a Milano, a Torino. Trovano subito lavoro. Qui sta accadendo quello che accadde nel 1911 e’12; dopo Tripoli.
Migliaia di Capovespresi andarono chi in Argentina e chi nell’America del Nord.: a Bruccolino, a Tampa, a Detroit.
L’informazione di Botta era esatta. I primi a partire da Capovespro furono i fratelli Canale. Aprirono la via verso il continente e di là verso la Germania, la Svizzera e persino verso l’Inghilterra.
Il benessere incominciò a vedersi a vista d’occhio. Corsero ben presto voci sulle consistenti rimesse che gli emigrati spedivano alle famiglie. Le quali, a loro volta, depositavano i soldi nell’unica Banca del paese per pagare i debiti, acquistare una partita di case, una «broscia» di terreno, completare la dote di una figlia, o di una o più sorelle.
Ora c’è da dire che a causa delle guerre, da quella di Spagna e dell’Africa Orientale, a quella che venne chiamata Il Guerra Mondiale, la popolazione di Capovespro registrava un calo degli uomini e un esubero delle donne. Le quali reclamarono, presso i loro genitori, il diritto di emigrare anch’esse. Nel Vallone non c’era che la miseria, vita grama e pesante per le ragazze, il cui destino, da tempo immemorabile, fu
—
sempre lo stesso: accudire alla casa, nel tempo libero al ricamo della biancheria da sposa, in attesa di trovare marito, e, trattandosi di famiglie numerose, dedicarsi alla custodia e all’allevamento della prosapia minuta.
Lunghe discussioni si facevano dal mattino alla sera; su questo nuovo versante umano, l’abilità di Lorenzo Botta, Mimato ed apprezzato in tutto il quartiere, per le sue doti e i 1 dono del «consiglio», ebbe ancora una volta un ruolo decisivo.
Da parte loro, le ragazze dimostravano ai genitori che i !empi, in cui una figliola stava attaccata alla gonnella della madre, erano passati; che, in tempi più pericolosi per una ragazza, molte compaesane del Vallone, erano emigrate ben più lontano dalla Germania e dall’Inghilterra ma addirittura erano arrivate da sole in America. E citavano persino i nomi di quelle eroine: Angela e Maruzza Ingoglia, Pinuzza Lo Cicero, Graziella La Paglia, Fana Pitarresi.
– Noi, concludevano, non siamo meno di loro.
Ma il fronte unitario non restò compatto. Non mancarono, ovviamente, le défaillance, il timore reverenziale, gli atteggiamenti del padre padrone, la gelosia delle madri nella custodia delle figlie che, quasi sempre, era dettata da egoismo. Perchè una figlia rendeva molto nel lavoro casalingo.
Non tutte le ragazze, fin da quegli anni bui del loro vassallaggio, erano ligie ai genitori e supine ai fratelli a tal punto da accettare le regole dei primi esodi. Non importava un fico secco se i genitori e i loro fratelli ponessero veti assurdi e imposizioni mortificanti.
Così maturò, giorno dopo giorno, una sorta di emancipazione in seno al folto gruppo di giovani donne non ancora accasate.
Un miracolo, questo, per quei quartieri dove l’eccessiva modestia, la riservatezza e il pudore luccicavano subito attraverso il rossore delle guance che, tuttavia, andava sbiadendo, tanto da non arrossire più di fronte ad estranei o presentandosi ad un funzionario dell’Ufficio Provinciale del Lavoro.
torna sù
ROSA PINTO
Un amico della famiglia Pinto, trasferitosi da qualche anno nel capoluogo, tenne i contatti con la «Pasionaria» del gruppo. Ilaria, un’esistenza difficile: gracile, molto magra, una dei quattro figli di Rosa Pinto. Separata, Rosa, di fatto dal marito, Marco Monastero, dopo il primo figlio, continuò lo stesso a fare figli. Nel quartiere, però, nessuno la considerava una prostituta, un’«ingarzata». Anche se tale effettivamente era. E lei ne era pienamente a conoscenza. Non se ne vergognava: era questo il suo stato e basta, ne più ne meno di come si comportava Turiddu Magro. Il quale, pur essendo a conoscenza che la moglie lo tradiva e che per dipiù era puttana, non ne faceva una tragedia. A chi gli dava del cornuto rispondeva che lo sapeva che era tale e che non era il caso che gli altri glielo dicessero.
Un caso, questo del Magro, eccezionale in una terra dove la gelosia e le corna finivano a norma di quel codice che veniva definito di «cavalleria rusticana».
E tuttavia, questa condizione di Rosa Pinto era anomala rispetto al maturato senso comune dell’onore, e del disonore che comportava l’essere una donna pubblica. Perché di solito, nei piccoli quartieri, tale veniva considerata una donna. E, si aggiungeva, non dimenticando la Maddalena del Vangelo, «Peccatrice»; tanto che le bizzoche si segnavano passando davanti alla porta delle loro abitazioni.
—
Ma Rosa faceva eccezione. Era vista, la sua situazione, come costrizione di esistenzialità. «Deve pur vivere, povera donna»! Di peccaminosità nessuno del quartiere parlò mai: un modo come un altro per vivere e sopravvivere.
Posta al sicuro la sua condizione, della quale non si parlava neppure nell’ambito del quartiere, si pensò a salvaguardare anche la posizione dei figli che venivano alla luce. E i figli? Da considerare «opera dello Spirito Santo».
Un fatto normale. «Le sue doti coprono la moltitudine dei suoi peccati» – diceva il Parroco alle pinzochere che gli stonavano la testa per quella «peccatrice». La pecora nera – dicevano – della parrocchia.
Ma il parroco, che conosceva bene le sue pecore, redarguiva: «Non è l’unica; ce ne siete molte altre».
Delle tre figlie Monastero, perchè col nome del marito le portava al battesimo appena nate, Ilaria non appariva figlia ne dell’uomo che più degli altri la frequentava, nè tanto meno dell’uomo che l’aveva piantata: Marco Monastero. Nè di sua madre che la diede alla luce e che la portò al battesimo dandole quel nome.
L’idea del nome, in verità, non fu di Rosa che non sapeva esistesse un nome così strano, anche se suonava bene. Fu un monaco che, in supplenza del Parroco, ebbe l’onore di battezzare la figliola più piccola di Rosa Pinto, che suggerì quel nome. E quando Rosa, circondata dai cogiunti, chiese: «Ma chi è questa Santa»? Il monaco le spiegò: Sant’Ilario fu un grande santo. Oggi, 13 gennaio è la sua festa. Non è bello chiamare questa graziosa bambina «Ilaria»? «Sta bene – disse Rosa -. Io veramente – non potè fare a meno di precisare Rosa – avevo pensato di chiamarla Anna – Chiamiamola Ilaria».
—
Il nome Ilaria piacque a tutta la famiglia.
Gli antichi, nel nome che davano ai figli, sognavano presagi sul loro avvenire. La tradizione, nel mondo cristiano, veniva e viene a tutt’oggi dalla Bibbia. Per alcuni predestinati fu lo stesso Javè in persona a dettare il nome. Nessuno, nel nostro caso, pensò che Ilaria avesse un significato di arcana predestinazione. Un nome, come tanti, che si dà a chi dal buio fecondo dell’utero viene alla luce.
Nessuno dei pochi congiunti presenti ebbe l’idea di chiedere al frate battezzante chi fosse Sant’Ilario. Il quale viene chiamato di Poitiers, la città di cui fu Vescovo, e che scrisse tanti libri contro gli eretici ed altrettanti commentari biblici. Ma di più viene citato per l’opera «De fide et de Trinitate».
I registri dello Stato Civile dei nostri municipi sono ricchi di cognominazioni esaltanti. Se ad un neonato girato alla «nota» fu imposto il cognome di Alfieri o di Verdi per un capriccio dell’Ufficiale addetto allo stato «civile», a sua volta quel neonato, divenuto adulto, padre di figli, non poteva esimersi di mettere accanto al cognome il nome di Vittorio o di Giuseppe.
Questo quando il funzionario comunale era uno che si intendeva di letteratura e di melodrammi. Ma accadeva il peggio. Ciò avveniva quando un presuntuoso impiegato a corto di comprendonio si librava in più alte aure. Ad un bambino trovato tra gli sterpi di una roggia da due contadinotti, fu dato il cognome di «Perbacco» e il nome di «Fortunato». Perchè? Perchè i due raccontarono all’impiegato dello stato civile come rinvennero quel bambino, e della loro meraviglia, tanto da esclamare, il primo, «Per bacco!», e, l’altro, «Fortunato». Perchè, significò quest’ultimo, che a sua volta fu impallinato, sempre da un impiegato comunale, con il nome «Chiodo», é stato veramente fortunato: gli abbiamo.
torna sù
FORMICHE IMPAZZITE
Ilaria che s’improvvisa, ora, «Pasionaria» del diritto delle donne per trovare lavoro e fortuna, era cresciuta come tutte le altre sue coetanee: scuole basse, vita di lavoro casalingo, sogni e sospiri.
Tutto qua. In rari casi si poteva accedere ad un apprendistato di cucito e ricamo. Non più di questo.
Ma in quegli anni, finita la guerra, ci fu una ventata di novità: voglia di sapere, di conoscere che entrava nelle case con un impeto veloce e invadente; più invadente della fame che c’era nelle case, in quei vicoli e cortili angusti, remoti rispetto alla strada grande del paese.
I partiti politici, i sindacati, l’azione cattolica, facevano conoscere un palmo in più di diritti di quanto ne avessero conosciuto le ragazze e i giovani contadini degli anni quaranta.
Però, soffocati sempre si sentivano dalla paura della guerra e, dopo, da quella della disoccupazione. Come formiche impazzite, in cerca di semenze da immagazzinare, brulicavano inarrestabili per le nuove vie che, di giorno in giorno, andavano scoprendo.
La TV arrivò impetuosa. Il primo apparecchio televisivo – manco a dirlo – entrò nel circolo dei Nobili. Poi negli altri circoli sociali e nella sede dell’Azione Cattolica.
Nel giro di pochi anni, perfino le famiglie meno abbienti, ne entrarono in possesso, a costi altissimi. Un boccone in meno, per acquistare, in diluite rate, il «cinema in casa».
—
Fu così che Ilaria incomincio a cimentarsi con i nuovi modelli di comportamento. Nuove cognizioni, nuove problematiche. Un passaggio difficile: dalle incertezze alle certezze sperate, dai dubbi alle perplessità, alle passioni, ai sogni.
Il piccolo schermo la stimolò anche alla lettura, sebbene unico titolo di studio conseguito fosse la quinta elementare: in poco tempo, passando da un libro all’altro, riuscì perfino a masticare argomenti ardui e complessi per la preparazione scolastica che possedeva. Andava al di là del romanzetto di Carolina Invernizi o Guido da Verona.
Leggeva di tutto. La storia l’avvinceva. Ma era la letteratura in genere che preferiva: Capuana, Verga, Pirandello, Vittorini erano i suoi preferiti. Silone e Carlo Levi e, poi Pasolini e perfino il difficile Gramsci, che lesse e rilesse più volte, erano pane per i suoi denti.
Lorenzo, il calzolaio dei vicoli dove si svolgeva la vita di questo piccolo mondo, che le forniva i libri presi in prestito dalla biblioteca della Sezione «Gramsci», se ne sbalordiva.
– Ma li leggi davvero tutti questi libri e così presto? Ilaria lo guardava con commiserazione e gli rispondeva: – Certo che li leggo. «Vuoi che ti parli del Viaggio in Sicilia» di Elio Vittorini? o dell’«Avventura di un povero cristiano» di Ignazio Silone?
– «No, no – rispondeva spaventato Lorenzo – non lo voglio sapere. Ne voglio sapere come fai, in così pochi giorni, a leggerti un libro così» – e faceva un gesto con il palmo della mano che poggiava sul bancarello e che alzava sino a dieci centimetri.
Della letteratura russa faceva lezioni a tutto il vicinato.
—
«Guerra e Pace», «I Fratelli Karamazov», «Anna Karenina», «La Madre».
Raccontava tutto in modo così preciso e avvincente che quel poco di casa che aveva si riempiva a prima sera di uomini, donne e giovani del quartiere. Sino a dieci minuti prima delle ore venti. Perché subito dopo occorreva accendere la TV. Ma erano poche le sere che trascorrevano davanti al piccolo schermo. In questo mostrava la sua superiorità a fronte della mania in cui precipitavano le sue compagne, di starsene inchiodate dinanzi al video anche quando trasmettevano idiozie e banalità.
Non meno sbalorditi di Lorenzo erano i vicini di casa.
– Come ha potuto fare questa piccola «cosa» di Ilaria a diventare tanto istruita? Un mistero. Pare come se le fosse calato sulla testa lo Spirito Santo in persona.
Del quale Spirito Santo sapeva poco e nel quale credeva ancor meno di poco. E non per ragioni di diffidente scetticismo, bensì per motivi che potremmo definire di «partito preso». Il quale non di raro rivela astio profondo contro il governatore dell’universo per il fatto che l’avalla, oppure non se ne cura. O, più probabile, che non c’è.
Un’evidenza, tuttavia, ben nota all’intelligenza del vicinato e, perfino, all’osservazione del giovane Parroco, era questa: Ilaria non leggeva e studiava per propria dilettazione, ma per gli altri. Faceva ripetere agli ascoltatori quel che aveva letto in quelle quotidiane assemblee.
Insomma col crescere degli anni era divenuta una «Intellettuale organica». Delle letture di Granisci qualcosa di buono veniva fuori.
L’idea della madre era quella di farle seguire la sorte delle sorelle. Compiuti i diciotto anni, le mandava dalle collegine.
—
Se ne avevano voglia, le suore le facevano studiare perché divenissero, a loro volta, suore anch’esse. Se non ne avevano, restavano lo stesso in Collegio a sfaccendare sino a quando non si fosse presentato il partito giusto per andare a nozze.
Rosa Pinto era costretta a questa decisione dal suo «stato».
Mandare le figliole in collegio significava non avere bocche da sfamare; ma anche essere libera di lavorare: ospitare cioè qualche cliente; l’arrivo della «divina provvidenza», dato che il suo commercio si svolgeva in amore; e basta.
A Ilaria, compiuti i dieci anni, aveva incominciato a parlare di Collegio. La ragazza oppose un netto rifiuto. Non si era resa conto, la madre, che Ilaria era un pezzo di Monastero diversa dalle altre sorelle. Era abbastanza intelligente per far finta di non capire del mercimonio della madre. E sperava tanto di crescere presto in anni e in saggezza per riscattare la madre. La quale, a sua volta, deprecava sè stessa e la sua sorte.
– Si, è vero – ragionava tra se Ilaria – che per tirare avanti la piccola famiglia occorrono soldi; ma è pur vero che una donna non può vivere così: vendere la propria carne al primo cliente è il piú assurdo mestiere di una donna.
Lei stessa, per dimostrare alla madre che esistono altri modi per guadagnarsi da vivere, dedicava l’intera mattinata a ricamare.
Si alzava di buon’ora, prima ancora della madre e, senza concedersi riposo, sgobbava sino alle prime ore del pomeriggio. La reputazione sulla madre, che per altro non era mai stato scandalo per il vicinato, aumentò in positivo. Di Ilaria e della sua finezza nel lavoro del telaio e dell’uncino si parlò persino fuori
* * * * *
del recinto del quartiere denominato, da antica data, Vallone. La retribuivano bene, per quanto lei pattuiva e voleva che le dessero, e di fatto le davano.
La madre, però, non era meno della figlia in intelligenza e astuzia.
Non era un’allocca; chè una fa una figlia intelligente è difficile che intelligente non sia. Rosa capì l’antifona e prima ancora che la figlia entrasse nell’età dell’intendere e del volere, prosciugò le sorgenti dell’utero per dedicarsi al ricamo che la figlia, a sua volta, le fece riprendere dopo tanti anni di abbandono.
Intanto, delle sorelle maggiori una prese il velo di collegina e fu suora. L’altra andò a nozze con un giovane americano, figlio di siciliani, che una siciliana pura voleva, siccome era uscita dal grembo materno.
Il giovane era nipote della Madre Superiora. Quanto dire per garantire di che frumento veniva la farina. L’unico maschio, Melchiorre, che precedeva di quattro anni Ilaria, era stato preso a «figlio santo» da una zia che lamentava di non avere avuto la fortuna di fare un figlio. C’è da dire che a Capovespro, il paesino dove si svolgono queste vicende che stiamo narrando, chiamavano «figli santi» i ragazzi o le ragazze appartenenti a famiglie numerose, che venivano ceduti a parenti o benestanti, privi di figli. Una sorta di adozione, ma adozione non era: uno stato di fatto, insomma. Al «figlio santo» si faceva la promessa dell’eredità dei beni, mobili e immobili e relative pertinenze.
Ilaria, alla madre che le sollecitava a trovare un «merlo», cioè un marito, rispondeva con le parole della Bibbia: «C’è un tempo per tutte le cose: un tempo per sposarsi e un tempo per morire, un tempo per mangiare e un tempo per stutiare, un tempo per fare figli e un tempo per allevarli…».; parole che citava allontanandosi dal testo originale. Ma la sostanza è biblica. Perchè, Ilaria, i libri della Bibbia li conosceva bene.
Anzi più che conoscerli li studiava approfondendone i significati, le sentenze, i punti oscuri. Da sè, senza l’aiuto, manco a dirlo, del Parroco. Perchè, allora, sino all’avvento di Papa Giovanni, la bibbia non poteva andare nelle mani dei «fedeli» che non fossero addottrinati: usciti, cioè, da un’alta scuola cattolica. Le edizioni che andavano in giro erano rare. Quella che possedeva Ilaria risaliva agli ultimi anni del ‘700, edita a Napoli. Gliene aveva fatto dono una vecchia nipote di un canonico.
UN TEMPO PER TUTTE LE COSE
E venne il tempo della scelta: l’emigrazione. A dispetto del quartiere e delle madri matrone.
La scelta, di questa specie di fuga dalla propria terra, non fu indolore né per le ragazze ne per i familiari.
Sebbene la madre di Ilaria fosse di strafottente comportamento, nel senso che non sottilizzava molto sulle scelte delle figliole, sacramentò più delle altre contro la sorte infame, contro il governo, contro tutti i responsabili della cosa pubblica, che per un tozzo di pane manda i ragazzi e le ragazze, i vecchi e i meno vecchi in Germania, in Svizzera, in Francia, in Inghilterra e perfino in Venezuela. E comunque, tra le lacrime, Rosa raccomandava a Ilaria: «Lariuzza mia, pensa sempre alla mamma. Non mi fare impazzire di pena e di dolore; scrivi, la mamma. Va bene»?.
Quel mattino una folla di parenti era attorno all’autobus. Molte lacrime, pianti frenati a stento, visi tirati di anziani genitori.
Rosa strinse forte la figlia al cuore e non sapendo come benedirla, chè a queste cose non era abituata, la baciò da soffocarla, segnandole istintivamente, con una crocetta, la fronte.
Nell’allontanarsi dal suo paese per andare a prendere il treno a Palermo, pensava alle lacrime di Lucia Mondello, ai pensieri del Pellico, deportato allo Spielberg in Moravia, nei pressi di Brno, all’esilio di Gramsci e di tutti i patrioti di tutti i tempi.
* * * * *
Quanti gliene erano passati sotto agli occhi nelle sue diuturne letture!
E mentre le altre compagne di emigrazione si tergevano gli occhi, lei se ne stava dura, arcigna sul treno che, per la prima volta vedeva dal vero; anzi vi era seduta su sporchi cuscini di «velluto ferrovia», come venivano chiamati i velluti delle carrozze. In corsa, per la prima volta in treno: bello e mostruoso a un tempo, che ti fa sognare e ti distrugge. Guardava attraverso il finestrino le verdi vallate, i filari degli alberi, tutti uguali, gli uliveti, i villini dei ricchi e le «robe» dei poveri, dei contadini, le greggi bianche, i paesini arroccati sulle montagne per non essere preda di compagnie di ventura; e le città distese nelle grandi pianure, e gli uomini che vi abitavano e vi lavoravano.
Pensava: vi abitano e vi lavorano. Ma perché non dovremmo, tutti allo stesso modo, trovare lavoro dove siamo nati e viviamo? Perché mezza Sicilia, mezza Calabria, mezza Puglia, la metà di ogni singola regione d’Italia, deve andare all’estero per lavorare e mangiare?
E dove il treno filava sulle ore del tramonto, lei passava alle dolcezze della casa. Una casa povera: una stanza per il ricamo, a piano-terra, in mezzo alla strada, si può dire; un’altra dove dorme la mamma, arredata con i mobili del matrimonio. Mobili, si fa per dire, ché sono fatti di assi di abete pitturate con vernice; ma tanto belli per i poveri che solo di questi mobili adornano quel pò di spazio che hanno; poi, un camerino per il fratellino e poi la sua stanza, che era quella delle tre sorelle. Tutte e tre di passaggio da quella stanza. Di là si passava poi nei cameroni delle collegine. Eccetto lei che in quella stanza lesse pile di libri, sino a notte fonda, in compagnia di personaggi a lei tanto cari, con autori che immaginò
—
seduti dietro una scrivania o su un rozzo tavolo o su un lurido bancone di galera.
Le altre ragazze, calato il buio, aprirono i cestini per prendere un boccone. Anche Ilaria, digiuna dal mattino sino a quell’ora, sentì lo stimolo dello stomaco vuoto.
Il viaggio prosegui per parecchi giorni. Destinazione il Sussex che si trova in Inghilterra. Ilaria aveva fatto lezioni di geografia e storia sul costume, le abitudini, il tipo di lavoro da affrontare, l’educazione che devono avere nel conversare, o farsi capire alla meglio, con gli inglesi.
Le educava anche alla conoscenza delle regioni che attraversavano, quando non si immergeva nelle considerazioni contemplative.
La notte si concedeva al riposo.
Le terre di Francia le ricordarono le vicende della Rivoluzione e i grandi romanzieri del periodo pre e post rivoluzionario. Dai due Dumas a Victor Hugo, a Stendhal, George Sand ed Emmanuele Navarro.
Superata la tristezza dei primi giorni, si improvvisò guida turistica per le compagne di viaggio che ne volevano sapere di più di quel che vedevano. Non si stancava di parlare e citare nomi, luoghi, città, vicende come quella toccata a Giovanna D’Arco, a Luigi XVI e alla moglie Antonietta d’Austria, ghigliottinati. La gloria e la deblacle di Napoleone che, da semplice ufficiale, si autoproclamò Imperatore dei Francesi.
Finita la narrazione storico-geografica, si piombava nel silenzio e nel ricordo delle persone e delle cose, degli affetti o degli amori lasciatesi alle spalle.
«Senza rimpianti». Questa era la lezione che dettava Ilaria.
—
«Non siamo più bambine. Siamo adulte. Responsabili della scelta che abbiamo fatto.
La scelta era già di fronte ai loro occhi. Lasciata Calais, furono traghettate nel porto di Dover. Erano già in Inghilterra. Poche ore di treno ed ecco Petworth nel Sussex: il posto di lavoro come dal contratto firmato.
Alla stazione era ad attendere le venticinque lavoratrici italiane, anzi siciliane, un inglese che si faceva intendere bene dal nostro gruppo. Ilaria interloquì per il gruppo: s’improvvisò, meglio, si autonominò caposquadra, senza me7zt termini. Si presentò al giovane inglese con la massima disinvoltura, presentando la squadra.
Il signore inglese si presentò a nome della Ditta. Era pronto un pullman per trasportare troupe e bagagli negli alloggi adiacenti alla fabbrica nella quale avrebbero iniziato, il giorno dopo, il lavoro. Dieci minuti di viaggio ed ecco la «Industry Staff Fruit’s in the box» che in tutta la vicenda che stiamo narrando indicheremo con la sigla «Isfab».
Gli alloggi che approntava la Ditta erano di emergenza. Entro il mese le lavoratrici dovevano trovarsi degli alloggi a proprie spese. Si trovavano facilmente. Gli addetti alle pubbliche relazioni della «Staff Fruit’s» avrebbero guidato le raga7.ze nella scelta delle abitazioni a contenuti costi di mercato. Ogni ragazza fu dotata di guanti, camice e berretto bianco. E di un libretto di lavoro. I quattro giorni di viaggio Capovespro-Petworth a vuoto per pieno: un omaggio per la fatica sopportata dalla Sicilia sino al Sussex
Il lavoro fu iniziato con grande slancio. Si trattava di un lavoro fatto apposta per le donne, ripeteva ogni giorno, il giovanottone inglese che le aveva prelevate dalla stazione al loro arrivo. Nessuna lamentela, infatti, venne sollevata circa
—
il lavoro che veniva disimpegnato con scrupolo da parte delle ragazze e, con grande soddisfazione della Ditta.
Intanto trovarono subito gli appartamenti di cui avevano dato indicazioni gli addetti della fabbrica. In ogni appartamento trovarono posto cinque ragazze. La privacy si personalizzò.
Ilaria trovò positivo l’impatto con la nuova realtà e stimolò più di una della carovana a non lasciarsi andare alle nostalgie e ai rimpianti. «Il contratto – ricordava Ilaria – era stato firmato per due anni; occorre stringere i denti. D’altro canto non mancano i contatti con la famiglia. I telefoni funzionano bene e anche la posta arriva puntuale».
Il salario era soddisfacente; ottima la mensa. Si poteva mettere da parte un pò di sterline. Non erano granché. Ma a fronte del nulla che percepivano al Vallone di Capovespro la «Fruit’s» era divina provvidenza. Certo occorreva pagare l’affitto dell’appartamento, le spese della colazione e della cena, le spese delle telefonate e via dicendo.
Restava poco – lamentavano alcune ragazze.
– Non c’è motivo di lamentarsi – redarguiva Ilaria -. Il ricamo, l’uncinetto, le fatiche quotidiane ci davano forse di più di quanto guadagnate qui? Questa terra, per noi, é «terra promessa». Lavoriamo e tiriamo avanti. Basta con i piagnistei.
Molti erano, nel Sussex, gli italiani che vi lavoravano: Pugliesi, Campani, Calabresi e tanti altri siciliani. La maggior parte degli emigrati del Sud d’Italia si improvvisarono giardinieri. Un’arte congeniale per il bracciantato generico delle regioni meridionali. I più dotati si cimentarono coraggiosamente nella floricultura. Ci riuscivano tanto bene che, constatata la grande richiesta che veniva da parte degli inglesi,
—
molti si diedero alla piccola imprenditoria. Si fornirono di un furgone cabinato, si crearono una squadra di ex contadini, sopraggiunti nel Sussex in ondate successive, prendevano appalti annuali per la manutenzione delle villette, dei giardini, dei rèsidences. Un piccolo impresario siciliano, anzi compaesano del nostro gruppetto di ragazze, da bracciante divenne ben presto piccolo, ma intelligente imprenditore. Seminava ogni mattina i braccianti giardinieri qua e là dove occorreva. Li riprendeva, poi, nel pomeriggio per ricondurli a casa. A fine settimana li pagava.
Questo fatto, dei lavoratori siciliani in quelle contrade, fu di grande conforto per le nostre pioniere.
In certo senso si sentivano «come a casa». Si vedevano spesso, scambiavano qualche parlata dialettale o qualche espressione come «Quant’è bedda la nostra Sicilia», organizzavano il fine settimana per trascorrere qualche ora insieme. In genere facevano a turno nella scelta del luogo della «cenetta-insieme». Quando erano in molti a prenotarsi sceglievano una pizzzeria, manco a dirlo, gestita da meridionali,
che ce n’erano molte, e vi trascorrevano la serata allegra. Da questi incontri vennero fuori anche dei matrimoni. Una mezza dozzina di ragazze, tra le quali Caterina Napoli, Lilla di Stefano, Giusuzza Lipetri, Maria Audenzia Interrante, andarono a nozze con giovani campani e pugliesi
torna sù
NEL GIRO DI POCHI MESI
Per Ilaria, tolta la nostalgia delle letture, la vita inglese offriva un habitat vivibile. Era contenta del sogno realizzato, dello stesso lavoro, delle amicizie fatte. Anche con gli inglesi inizio un buon rapporto di convivenza. Acquistò subito un vocabolario inglese-italiano. Dopo il boccone della cena, si sedeva sul letto, mandava a memoria le parole correnti e le più usate. L’accento lo apprendeva sul posto di lavoro o tra gli inglesi dei mercati dove andava a fare la spesa in compagnia delle compaesane. In poco tempo s’impossessò della lingua. Un «apriti cielo» per riprendere le tralasciate letture. Nel giro di pochi mesi, oltre a mettere da parte qualche risparmio, immagazzino un sacco di nozioni. Memore di quanto Lorenzo Botta, il calzolaro comunista, che le forniva i libri del «partito», le diceva, ora lo metteva in pratica. E che le diceva Lorenzo? «Ricordati, Lariù, che se non vuoi farti fottere dal padrone, tu devi conoscere una parola in più di quella che conosce lui. Lui ne conosce cento, tu ne devi conoscere cento e una». Col giovanotto inglese non parlò più a «nimma»: cioè senza farsi intendere abbastanza bene; ma in inglese elegante; quasi raffinato.
E nonostante le sue vittorie, mal celava un’indisposizione interiore ad accettarle. Certo, non pensava che le sue conquiste fossero state furto. Un furto ai danni di chi?. L’essere riuscita a tanto: a saper leggere e scrivere meglio di un laureato, l’avere avuto il coraggio di superare la riottosità del contesto del quartiere, l’aver guidato sino in Inghilterra una consistente carovana di assetate, come lei, di ……………….coming soon
Il saluto fu imbarazzante. Ognuno dei due pensava ad un abbraccio innocente così come entrambi, in cor loro, desideravano: toccata e fuga di guancia a guancia. Non ci fu. E sia l’una che l’altro, come due bamboloni che si pentono di non avere accettato un dolce per eccesso di civile educazione, così i nostri si morsero le labbra per l’occasione perduta.
torna sù
L’OPINIONE SU «DIO»
Per la prima volta un viaggio in aereo per Ilaria: destinazione Punta Raisi. Un’ebrezza che avrebbe gustato di più se non ci fossero stati gli eventi delle ultime ore. Passò e ripassò, nel proscenio della fresca memoria, una per una le parole, i gesti, il volto di William. Ne sbobinò le sequenze soffermandosi nei passaggi più cruciali e decisivi. Perché anche i fatti più dolci della vita hanno una propria sofferenza: tanto indicibile, a volte, da superare il dolore fisico. Basti pensare alla sofferenza gioia di una madre che dà alla luce una creatura. O alla gioia che arresta i palpiti del cuore.
Immersa com’era nel lavorio della sbobbinatura di quella pellicola interiore, non si accorse di avere sorvolato il candore delle Alpi, di essere arrivata allo scalo del Leonardo da Vinci.
L’aeroporto dell’Urbe la destò da quella dolce estasi in cui era entrata da Londra sino a Roma. Dove occorreva attendere per circa un paio di ore.Gironzolò a lungo per i grandi Stands. Per ammazzare quelle ore comprò un paio di riviste. Ammirò le boutiques dove erano grandi esposizioni di firme famose: Dior, Gucci, Valentino. Curiosità più che valutazione sui «tesori», se così può dirsi, che offre alla voluttà femminile e maschile, l’estetismo più raffinato.
Passarono così molto veloci quelle due ore. Lo speaker annunciò che era in partenza l’aereo per Palermo. Si sentiva, ormai, a due passi da casa dove arrivò a un tocco a
—-
mezzo giorno. E questo grazie all’automobile che mamma Rosa mandò all’aeroporto.
Al suo arrivo trovò la folla del vicinato assembrata nell’angusto spiazzale della sua casa. Abbracci, baci, commozioni sino alle lacrime; domande pertinenti e impertinenti, complimenti, carezze.
– Che succede? gridò Lorenzo, il calzolaio che, pur essendo a conoscenza dell’arrivo di Ilaria, ne aveva scordato l’orario.
– Ilaria? Oh miseria puttana..! Grida e si precipita a razzo verso la casa di Rosa. Piange a diluvio. Si asciuga gli occhi col grembiule di rozza alona che é più ruvido della carta vetrata numero quattro.
Non fa niente. E festa, oggi. E di seguito i commenti: «Era bella Ilaria, quando partì; ma ora é chiù bedda di prima, assai assai!».
Se questo avvenne tra la folla del vicinato, può immaginarsi quello che avvenne tra Rosa e sua figlia. Un abbraccio lungo; lungo come i tocchi dell’orologio di San Giorgio dei Turchi che batteva cento colpi.
C’erano ad attenderla anche le altre emigrate del gruppo che da Londra, sempre in aereo, erano arrivate una settimana prima.
Festa da grande evento. Mancavano solo i petardi e la banda cittadina.
In cor suo, dopo tanta baldoria, Ilaria sperava che la lasciassero un pò tranquilla. Voleva sentirsi sola per chiudere gli occhi e pensare. Pensare la sua vita daccapo. Partendo, non da quelle otto ore che la separavano dalle chances di William ma da quando, ancora bambina, guardava le stelle, la luna piena e desiderava di conoscere il padre, o un padre.
Quel sentirsi chiamare dalle compagne di gioco «Ilaria, la figlia di Rosa», mai la figlia di Tizio o Filano, era mortificante: un’umilazione. Anche la madre, che raccoglieva quella mortificazione, la rassicurava dicendo che nel vangelo Gesù mai venne chiamato «figlio di Giuseppe» o figlio del falegname, ma sempre figlio di «Maria». Ecco, é il tuo caso – diceva la madre -; e per rafforzare la tesi aggiungeva: «E più semplice dire `figlia di Rosa’ e basta. E meno di «Monastero» o di vattelappesca».
Anche se il ricorso alla celia della mamma non la convinceva, l’accettava lo stesso col sorriso che sboccia sulle labbra degli innocenti che non hanno, purtroppo, argomenti da contrapporre alla filosofia degli adulti.
Come Dio volle, la folla del vicinato andò diradandosi sino all’esaurimento. Il pranzetto preparato dalla mamma: -tanto quanto bastava per infilare qualcosa nello stomaco. Nonostante le pressioni materne, il dippiù che poté infilarci, fu una grossa pesca.
– Ora, mamma, voglio riposare. Dirai alla gente che viene, per visite e chiacchiere, che io sono sfinita e voglio saziarmi di sonno.
In realtà stressata c’era, come chi, finito il lavoro, si appresta, poi, ad intraprendere un’altra fatica più pesante dello stesso lavoro, il viaggio in aereo. No, e un dolce sollazzo. Una fatica, si, di certo e quella di riandare con serenità, senza essere molestati da alcuno, a ricostruire una vita arrivata ora al punto che viene sempre definito il più importante; ma che dopo ci si accorge essere come gli altri. Ai quali, purtroppo, per ingannare noi stessi, si annette la definitivita. Certamente non tutti i traguardi sono uguali. Ce n’è di più importanti e di meno importanti; non è forse tra i più im
—-
portanti quello della scelta di un compagno, di un marito, cioè? Non solo importante, ma faticoso anche.
Ilaria aveva l’esperienza vivente in casa. O fu la madre ad essere cieca a sposare Marco Munistero, o fu cieco il padre a sposare Rosa Pinto. O se non furono ciechi entrambi vuol dire che lo divennero dopo, quando ognuno andò per la sua strada. Rosa, quando si prendeva questo discorso, incolpava la sfortuna che, in fin dei conti, è Dio. Se quel Dio che è nei cieli, avesse voluto che noi non andassimo uno a destra e l’altro a sinistra, avrebbe disposto le cose diversamente.
Per dire che vissero insieme solo per qualche anno, misino a che nacque il primogenito, Melchiorre. Il quale, poverino, come le sorelle, non ebbe neppure la fortuna di bisbigliare: papà.
Riconosceva, ora, Ilaria che, sì, tra due ci possa essere anche incomprensione, incompatibilità di carattere; ma arrivare al punto in cui arrivarono i suoi genitori è, più che volontà d’uomini, destino divino.
Il ricorso, al tempo che fu dei genitori, non era un ricorso alla giustificazione dell’incapacità del volere, ché anzi, decisionista com’era, riusciva a piegare la volontà dove e come lei voleva. Un «bulldozer» la definivano le colleghe di lavoro dietro le referenze che ne facevano le sue stesse amiche del Vallone di Capovespro.
Quindi, vediamo se William sta alla parola della telefonata e quali intenzioni, da baby English, intende rivelarmi.
Non nascondeva a se stessa la trepidazione, le eventuali delusioni anche. Perchè quelle cortesie, quelle premure forse avevano solo un riferimento al rapporto di lavoro. Dai padroni c’è da attendersi tutto. Quando il diavolo ti carezza significa che vuole l’anima. Quindi c’è da aspettarsi che ti ade
schi per una più forte presenza nella fabbrica, non solo sua, Ilana, ma di tutto il clan del Vallone. Dare l’anima, buttale sangue, meno sprechi di tempo, meno chiacchiere sulla ensa, sulle retribuzioni, sui diritti della maternità ecc.. Deve crepare se le sue intenzioni sono queste.
Non aveva sufficienti motivi per credere che le esternazioni effettuali mirassero ad una finalità così banale. Lo stesso savoir-faire inglese non lo consentiva assolutamente. L’Inglese può avere tutti i difetti di questa terra: egoista, calcolatore, presuntuoso, affarista; ma non mentirebbe sul piano dell’amore o dei rapporti di amicizia.
In quei due anni trascorsi a contatto con gli inglesi, di ogni tipo e inglesine di livelli sociali diversi, non ricordava di averne incontrato qualcheduno «facciòlo», cioè falso.
Il che, invece, le capitò spesso tra i giovani e le giovani di Capovespro. Le giovani, se vengono a conoscenza che un raazzo ti adocchia, ha delle serie intenzioni nei tuoi confronti vuole fare una dichiarazione d’amore, fanno di tutto per tai fuori da quell’innocente «Incontro». Non fu mai il caso dì Ilaria che anzi, ebbe più di un partito prima che prendesse la via dell’emigrazione. Inibita dalla storia materna, si avanzo, in questo terreno dei rapporti affettivi, con discrezione e dignità, lasciando il tempo al tempo, come dicevano i contadini del Vallone. In questo campo la sua saggezza fu superiore al merito del comune costume vigente a Capovespro. Sino alla partenza per l’Inghilterra Ilaria conservò alto il ruolo che aveva svolto nella piccola disgraziata famiglia circa il buon ostume. E lei stessa fu esaltata dal vicinato che la contemplava come la «Pulzella» del quartiere.
Non si inorgogliva, comunque, n’ di tanta dignità nè dell’altrettanta reputazione che le veniva da tutti.
—-
Il paesino di Capovespro era in un fazzoletto di terra, entro il quale si appollaiavano le casette di tufo arenano e un paio di migliaia di anime. Quando Ilaria incominciò a parlare dell’Inghilterra, come frontiera di emancipazione e di lavoro, in quel paesino la gente, per spiegare agli altri chi fosse, chè non la chiamava più nessuno figlia di Rosa Pinto, diceva: Ilaria d’Inghilterra.
Nel teatro del suo passato andava rimuginando ogni cosa. Ma tutto, annesso e connesso con l’inglese della «Staff-Fruit’s», William Harrison, che a Ilaria richiamava il famoso regista americano, Rex Harrison, per il film «Patrizia e il dittatore». E la connessione era la seguente: nell’ipotesi che l’inglese esponesse delle avances, in primo luogo lei avrebbe detto tutto della sua famiglia e del suo personale curriculum. Questo va da sè: nessuna misericordia su sè stessa, nessuna pietà da implorare ad alcun Dio. Non in senso generico ma individuale: il Dio del Parroco, della Bibbia, quello della Chiesa madre di Capovespro, che ne domina l’abside ed è di stucco, di stile barocco, con l’atteggiamento e le fattezze del Padreterno Pantocrator di Monreale. Proprio così. E dirò: sono così, figlia di Rosa Pinto, ma limpida e innocente, anche se furba e scaltra, come una delle figlie di Jetro, Séppora.
Su Dio non ebbe mai buona opinione. Scettica più che atea, lo considerava come uno che si fa i fatti suoi. Ne considerava l’esistenza migliaia, miliardi di anni luce dall’uomo. E nonostante Egli avesse inviato sulla terra a morire il figlio suo, distante fu e distante resta sempre dagli uomini.
Ma diceva a sé stessa che la questione su Dio è meglio riprenderla dopo. Quando? C’è tempo! Si sentiva in vena solo di riposo. Lo assoparava profondo. Quel lettuccio che ha
trovato lindo nelle lenzuola, nello stesso copriletto, nella stessa federa dalle frange ricamate; un ricamo tanto familiare che ricordava persino quando lei stessa iniziò a trapuntare, appena finita la scuola bassa.D’altronde che c’è da fare al Vallone, finita la scuola media, la scuola che è di un gradino più alta delle scuole basse? Cucire, rammendare, ricamare, fare il bucato e, se c’è la fortuna di quattro galline e un gallo, accudirli. Tutto qui.
Ma al ricamo si richiamava per ricordare la biancheria che, nel corso degli anni, nonostante le intense letture cui si dedicava, si era preparata con amore, come del resto si faceva,da parte di tutte le ragazze di Capovespro, appena entrate nell’adolescenza. Certo, ricordava, un tempo ci si teneva alla preparazione del «corredo»; ma oggi…. Solo tra noi, tra la povera gente usa fare tanti sacrifici. Chi ha soldi compra tutto. Avrebbe fatto anche lei così. Del resto, considerato che di un pò di corredo già disponeva, e al quale era affettivamente legata, si sarebbe trattato solo di acquistare alcuni indispensabili capi di biancheria. – E certo però che, se sposo un inglese, andremo a fare tutto ai mercati generali -.
L’ipotesi di un matrimonio con un inglese, la richiamò a Wiiliam.
Disse tra sè: «Oggi non telefonerà; e neppure domani, e chissà?, forse neppure per tutto il tempo delle ferie. Non farne un problema, se così sarà».
Ma anche se d’animo forte e di giudizio strafottente, diceva a sè stessa, ne avrebbe sofferto se William fosse stato solo una chimera e niente più. E faceva coraggio a se stessa: ce ne sono tanti uomini a questo mondo. Almeno – aggiungeva – sino a quando non ci saranno guerre.
Una vampata di calore la fece sudare al pensiero che il «caso William» si convertisse in una scatola cinese. Per ben due volte si voltò e rivoltò nel lettino a destra e a manca senza riuscire a trovare riposo. Si tirò da dosso la leggera vestaglia e tentò di addormentarsi.
torna sù
LORENZO BOTTA
Trascorse i primi giorni di ferie non movendosi da casa neppure per una passeggiatina come, ogni pomeriggio, le proponevano le amiche. Temeva che arrivasse una chiamata per il centralino. E non vedendo arrivare il fattorino, si stizzava con se stessa per avere confermato a William che avrebbe potuto telefonarle. Ripiombava nella considerazione che gli uomini, diversamente che le donne, sono di pasta frolla. Ma correggeva il tiro perché dalla massa voleva estrapolare qualcuno. Non certamente l’inglese di cui conosceva solo le qualità manegeriali e basta.
Qualcuno del Vallone. Mastro Lorenzo Botta, per esempio. Il calzolaio che Ilaria, priva di un padre, considerava qualcosa di simile ad un padre. Ed altri ed altri ancora. Ma volendo fare la conta si arrestava di botto. Non ne trovava altri. L’inglese! Già: ma che doti avrà al di là di quelle che rilevava in fabbrica? Dicono tutti: donne e buoi dei paesi tuoi. E per gli uomini? C’è un proverbio che ne assicuri correttezza e balle sode, fuori dell’ambito di questa sventurata terra?
Ci potrebbe essere, confermava a se stessa, per non castigare la sua speranza. Ricadeva subito, però, nel pessimismo, guardando l’orologio sul quale vedeva passare i giorni e le ore senza alcuna novità. Malediceva quell’ora in cui William le telefonò proponendole di accompagnarla all’areporto. Le salivano le caldane infocate dal viso alla vita.
—-
Mostrava abbastanza evidente la sua impazienza, tanto che Rosa se ne preoccupava. E da madre nerboruta qual era, senza peli sulla lingua e senza sottintesi, abbordò la figlia.
– Ilaria, siedi accanto a me e parlami chiaro. Da quando sei venuta da questa benedetta Inghilterra non ti ho visto un giorno bella, serena, tranquilla, dolce come sei sempre stata in vita tua. Mettiamo le carte in tavola e parliamoci chiaramente. Che cosa c’è in questo cervellino?
Ilaria si fece ancora più seria di quanta serietà avesse per le sue interne angosce e replicò subito:
– Potrei dirti, mamma,: sono cose che non ti interessano, come in altre occasioni parlando di altri fatti diversi da quelli che ti svelerò. C’è di mezzo un inglese. William Harrison, di cui parlo spesso.
– Ebbene?
– William promise, prima di salire sull’aereo, sì… non promise veramente. Mi chiese se poteva telefonarmi. Ecco tutto.
– E tu cosa gli hai detto?
– Che lo avrebbe potuto fare chiamando il centralino dell’ufficio telefonico di donna Francesca; così, come quando telefonavo a te.
Si, proprio così.
La madre leggeva sul volto della figlia un’indicibile angoscia.
Un disagio disperato raramente visto sul quel bel viso: il più bello tra quelli degli altri figli. Se ne accorò. Non seppe, li per li, dire qualcosa. La guardò a lungo con una dolcezza infinita: un’espressione che Ilaria non aveva mai osservato o colto sul volto della madre. La quale, appoggiando delicatamente la mano sui capelli della figlia, la incoraggiò:
– Non prendertela per così poco, gioia mia. È la prima
esperienza che stai facendo con un uomo. Che ti ha detto quest’uomo? Non ti ha promesso nulla, non ti ha fatto una dichiarazione di amore. Ti ha almeno dato un bacio?
Ilaria, scuotendo il capo, fece capire che il bacio non c’era stato.
– Ma un saluto forte con parole dolci almeno….?
– No! un saluto all’aeroporto, e basta.
– Vedi? Tu, figlia mia, con tutta la tua intelligenza non sai distinguere un saluto d’amore da un saluto-saluto, questo di Woillam o Willom come diavolo si chiama, fu un saluto-sa
luto?
– Ma non lo aveva fatto mai nè con me nè con le mie amiche, darci un saluto con stretta di mano. Capisci?
– Capisco una cosa, Ilariuzza mia: se questo inglese ha buona volontà e ti ama veramente, cioè che si è invaghito, capisci, di te, stai tranquilla; si farà sentire. Forse mentre parliamo pensa a te; o se la cosa è diversamente, che non ti pensa per niente e allora non è il caso di perderci la salute. Goditi, figlia mia, le vacanze.
Mamma, non puoi capire – e le spuntarono le lacrime -; quello che dici tu andava bene trent’anni fa; oggi è diverso. Uno se ti ama, ti ama, si vede subito. Io ho avuto questa impressione che William, sono certa, mi ama. Ha difficoltà, forse, a dichiararmelo questo amore. Non so: che devo dire?
– E allora, dato che io mi sbaglio – disse Rosa – aspettiamo questa telefonata. Ma in attesa della telefonata, figlia mia, non è che ti devi abbattere e mi cadi ammalata! Non lo vuole questo nè Dio, nè tua madre. Va bene?
—-
– Va bene!
La confidenza data alla madre la scaricò da quella penosa attesa.
Interminabile attesa: qualcosa che deve accadere e che non accade. Che incombe sulla coscienza ma non erompe. Conosceva bene Beckett.
Quell’«Aspettando Godot» è un terribile capolavoro dell’angoscia. Lo sentiva tutto nel suo essere, nelle sue carni, in quei giorni di torrida estate siciliana; giorni lunghi, interminabili. Dai quali non si poteva fuggire perché erano nella sua anima e nella sua carne. Attendere. Occorre avere la pazienza di Giobbe. Non franare nella disperazione o nel buio senza fondo dell’anima.
In verità la consolazione o l’incoraggiamento, che talora ci viene da una persona cara, è vera medicina dello spirito. Ilaria se ne senti sollevata al punto che andò a trovare il clan delle «inglesi», come tra loro si definivano. Le ragazze che, della malinconia di Ilaria, avevano subìto un fascino negativo, non hanno esitato a prepararsi subito per andare al mare. Il Mediterraneo che distava pochi chilometri da Capovespro. Una giornata di sole e di spensierata allegria.
Il mare era calmo: leggère onde lo increspavano lievemente. Un «piatto d’olio», lo definiscono i pochi pescatori che abitano e pescano lungo la «Costa Bianca». Le ragazze di Capovespro vi s’immersero cicalecciando ora sottovoce ora alzando le grida a seconda dei giochi che inventavano per mettere in disagio quelle che avevano paura del mare, o le altre, che non mancavano mai, nelle compagnie, che tuffandosi facevano le spavalde. Si immergevano sott’acqua per tirare i piedi alle timide che non avevano avuto mai dimestichezza col mare.
Ilaria si lascio andare ad una pazza allegria. Mise a tacere quella parte di sè stessa che si ostinava a tormentarla. Perché, in realtà, quell’angolo del nostro pensare, quando c’è il chiodo fisso, resta sempre un chiodo fisso, anche se vogliamo occultarne la sua persistente presenza. Il sole infuocato della costa mediterranea, la sabbia ardente che veniva mitigata dai costumi inzuppati e dalla frescura della brezza mariva, piacevano e, in certo senso, accentuavano la voglia di tornare al «chiodo fisso». A cui, però, ritornava inevitabilmente, rimproverandosi che, stare a bighellonaree sulla spiaggia, era un lusso quando si sta in attesa di una telefonata.
La telefonata, certo.
– Raga7.ze, si rientra a Capovespro!
Malgrado le lagnanze della piccola troupe, non ci fu niente da fare. Era appena l’ora di una merendina. Chi ne aveva voglia poteva consumarla cammin facendo; o in pullman.
– «Il à», ci stai facendo perdere mezza giornata di sole; ma che ti rende?
– Si, che ti prende; che hai lasciato il bebè a casa?
– Altro che bebè. Ho lasciato la «mamà» – rispondeva celiando.
– Domani ritorneremo di nuovo al mare e ci resteremo sino al tramonto! –
– Bum! Ci sarà un miracolo o uscirai di senno?
– Lo saprete domani.
Giocava ad indovinare circa il domani; che restava, tuttavia, condizionato alla cornetta del telefono di Donna Francesca, la telefonista locale.
Esiste, senza dubbio, il senso dell’intuito, dei presagio, che qualcuno chiama «sesto senso». Ilaria, da quel pomeriggio e per tutta la sua esistenza, sarà testimone di questo «senso» occulto; un senso che e in noi: una riserva privilegiata. Perché quell’invocato pomeriggio fu refrigerato dalla chiamata, a mezzo di garzone che la telefonista teneva a disposizione, di un avviso di telefonata per le ore 17.30. La telefonata, manco a dirlo, proveniva dalla città di Pertoti: così era scritto nel pizzino; ma che Ilaria interpretò subito: Petwort. In tempo per una doccia e scappare. Puntuale il telefono squillò mentre la figlia di Rosa Pinto varcava la soglia della casa di Donna Francesca, titolare telefonista della Società dei telefoni. William Harrison.
Era la sua voce. Diceva l’inglese che tutto era okay E cioè che non aveva potuto telefonare prima per chiusura di contabilità estiva, per mettere a posto ogni cosa. Ora tutto era okay: dichiarava che l’amava e che se lei, Ilaria, e la famiglia non hanno nulla in contrario, al suo ritorno avrebbero potuto sposarsi; al più tardi in autunno che lui amava pazzamente; che era un timido e che non sapeva come lei. Ilaria, avesse preso quella dichiarazione di mettere su una bella famiglia. E la mamma? Come prenderà mamma Rosa una tale proposta? Ilaria riuscì ad interromperlo. Gli confessò l’ansia penosa dell’attesa della sua telefonata. Ora finalmente era arrivata. Sì, anche lei è stata sempre, ed è, una timida; ma attendeva di sentire quella voce che le aveva chiesto «potrò telefonarti a Capovespro?». William le confessò il suo amore, maturato da tempo, ma che solo ora aveva avuto l’ardire di esternare. E forse questa esternazione avviene – diceva l’inglese – perché ci stiamo parlando per telefono. Di presenza non sarebbe stato coraggioso di fare una dichiarazione di amore. Si sono lasciati allo schiocco di numerosi baci e con la promessa che si sarebbe fatto
sentire, quarantotto ore dopo, alla medesima ora: perché aveva tante, tante cose da dirle.
Ilaria uscì dalla cabina perché chiamata da Donna Francesca. Ma era talmente intronata da non riuscire a muoversi dall’abitacolo.
Si sedette. Era trasudata per il caldo, ma molto di più per l’emozione. Chiese un bicchiere d’acqua. Donna Francesca, vedendola rossa, per il sole, ma smunta come un cencio strizzato per altre ragioni, corse subito in cucina, chiedendole il perché del malessere:
– Cattive notizie? Che cosa hai mangiato? Ti sono venute le «visite»?
Il mare non è sempre che fa bene alla salute. Di sicuro hai preso un’insolazione. Quanto ci sei stata in acqua?
– Non si preoccupi, Donna Francè. Cose da niente. Il mare mi ha messo qui, – e si massaggiò lo stomaco – l’inedia. E l’appetito. Ora vado a cenare. E passa tutto.
– Quant’è bella la gioventù! Se fosse venuta a me l’inedia a quest’ora sarei stesa per terra in attesa di qualche anima buona che mi desse una mano.
E per far capire ad Ilaria che lei è esperta in udito fine, aveva già capito. La baciò stringendorsela al petto. Poi le disse, con molta studiata ipocrisia:
– Ilaria, quant’è bello l’amore: si arriva persino a perdere i sensi. Vero?… solo a parlarne.
– Sì, donna Ciccina, specie quando si ha l’udito a posto e si ascoltano le telefonate dei clienti.
torna sù
LA «DUCEA DI NELSON»
La telefonista era abituata a digerire risposte salate. Ingoiò anche questa, come nulla fosse.
Ilaria mise le ali ai piedi per annunciare alla madre che il suo intuito non si smentisce. La madre é anche, tra le tante doti che possiede, profetessa di felicità per i figli.
Pianse Ilaria di gioia. Pianse la madre per la fortuna toccata alla figlia: che per bontà, intelligenza, bellezza, dottrina tutte le ragazze di Capovespro ammucchiate insieme, non hanno.
Alle quarantotto ore trascorse, Ilaria si presentò, non chiamata, al centralino di Donna Francesca. La puntualità e inglese. William, dopo i convenevoli, la mise al corrente del programma delle nozze condizionate dal comune lavoro. Le nozze si sarebbero celebrate entro la fine di settembre. Non occorrevano specifiche performances. Perché la «Staff Fruit’s» li mandava, in ottobre, a dirigere un grande complesso produttivo in Sudafrica.
Le ragioni di Ilaria per ponderare un pò il «pragma» proposto, il rapporto intimo e quello del lavoro con la Fruit’s, apparivano all’inglese pretestuose. Lei era perplessa: si contrastavano nel suo intimo la felicità e il dubbio. Le cose troppo belle, che lei, spirito fattivo, considerava troppo belle, e quindi fuori della fattualità, quindi irranggiungibili, le sembravano assurde nel pensarle e nel possederle.
—-
Perché tutto il divenire, dipanatosi in botto nel giro di pochi giorni, fu perentorio, tempestivo, fulmineo per lei, abituata alla ponderatezza siciliana e ai costumi e agli usi delle sue radici locali.
Non riusciva, insomma, a connettere. Balbettò qualcosa che l’inglese non colse bene. William che, da tempo a contatto con la comunità siciliana, ne conosceva l’anima, fu comprensivo. Ma occorreva decidersi per guadagnare tempo; sarebbe stato persino disposto a fare un salto a Capovespro per spiegare tutto di presenza, parlare anche con mamma Rosa che, pur non conoscendo, ne aveva un’idea fattas sull’immagine e conoscenza della figlia.
La proposta allettava Ilaria; ma l’angustiavano altri invadenti pensieri: la sua casa, la situazione familiare, il vicinato del quale non che avesse vergogna, che anzi ne era orgogliosa, ma ne temeva voci e commenti sulla onorabilità della madre e dello «status maritalis».
Decisa, però, come sempre era stata nel dare a se stessa e agli altri risposte risolutive, invitò William a scendere in Sicilia.
Il giorno appresso, a meno di ventiquattr’ore, il manage della «Staff Fruitt’s» sbarcò a Punta Raisi, dov’era ad attenderlo Ilaria con il fratello, Melchiorre. Raro possessore di una fiammante 128 di Capovespro.
Un incontro commovente e appassionato che superò la compassatezza del savoir faire inglese, di proverbiale notorietà.
William la informò di tutto. I suoi genitori ne erano al corrente: contenti anche per la scelta di una Siciliana e per il prospero avvenire cui andavano incontro entrambi. Lui le protestò la sua felicità e la certezza della scelta. Lei esternò la sua, accompagnata da ardenti sguardi. Un amore siciliano forte, violento che non le dava tregua – diceva – ne giorno ne notte.
—-
– Tutto okay allora? – Sì, okay!
Tutta Capovespro in un baleno fu a conoscenza della «fortuna» di Ilaria. Che tale veniva considerata la sorte di un buon matrimonio.
Più che d’invidia, le ragazze del Vallone, esplodevano di gioia. Lo meritava, la figlia di Rosa, un buon partito. È pur vero che Dio non abbandona gli «orfani». Tali considerava la gente i figli di Rosa per il fatto che un padre, in quanto padre, non conoscevano. L’adattamento agli usi della modesta casa di Rosa Pinto, da parte di William, lasciò capire a tutti, parenti, amici e amiche, che l’inglese amava Ilaria al punto di adattarsi a quella dignitosa modestia di una famiglia povera, ma onesta e sincera. E di una casa linda e odorosa di pulito. Questo vuol dire – si dicevano tra loro le comari – che questo inglese l’ama davvero. Un bell’uomo, un giovanettone che fa cadere gli occhi ammalati. Ma anche Ilaria è una bella figliola. Insomma una coppia da fare invidia.
William, da parte sua, fu contento di tutto, anche del quartiere e dei suoi abitanti che lo salutavano al suo passare.
Rosa aveva tirato dal canterano le lenzuola ricamate, le federe linde innastrate di trine, lo scendiletto di riserva, e persino un’orinaliera di noce scolpita appartenuta al nonno, e che teneva in riguardo per le occasioni.
Intanto che occorreva prendersi le ferie programmate, la calata a Capovespro del fidanzato di Ilaria, dava ad entrambi un’altra occasione. Anche se fu deciso di accorciare le vacanze, quei pochi giorni di distensione era bene li trascorressero intensamente. Melchiorre mise a disposizione della sorella e del futuro cognato, la sua macchina. Grande scoperta quella della Sicilia mediterranea da parte di William che non era uscito dall’Inghilterra se non per affari e,
—-
solo per pochi giorni, ospite in grandi alber i, in grandi metropoli. Le acque tiepide di «Costa Bianca», i grandi bacini archeologici di Agrigento, Selinunte, Mozia, Adranone, lo affascinarono: Ilaria, che ne conosceva bene la storia, spiegava nei particolari i dettagli, le vicende delle grandi antiche città nel corso dei secoli. E poi le angherie subite in Sicilia. Persino dagli Inglesi, che appoggiarono i Borboni di Napoli con la flotta al comando di Horatio Nelson. Al quale Ferdinando di Napoli, per gratitudine, fece regalo di un immenso feudo nel territorio di Bronte, chiamato «Ducea di Nelson». E che in appresso, nel 1860, costò la vita a molti contadini e notabili politici di quella cittadina perchè reclamavano l’abolizione della regalia, il feudo, per darne il possesso ai contadini che campavano di stenti e di miseria. E sai tu chi li ammazzò a fucilate? Il braccio destro di Giuseppe Garibaldi, Nino Bixio. I liberatori della Sicilia, per un falso spirito legittimista, soffocarono un’innoccente aspirazione autenticamente siciliana: la terra.
Ma questo è niente. Oggi ammiriamo i ruderi delle città, le cattedrali, gli anfiteatri, i templi, i monumenti innalzati persino ai più crudeli tiranni. Ma sapessi a che prezzo!
William si appassionava alle notizie storiche esposte in perfetto inglese da Ilaria, di cui ammirava, ora, anche un aspetto alquanto inedito per lui, abituato alle relazioni aziendali codificate, computerizzate, che la sua collaboratrice le faceva ogni giorno: la preparazione culturale, la sicure7Ja nell’interpretazione della storia, la logica nel ragionamento.
– A che prezzo? – chiese William.
Al prezzo di vite umane. I Faraoni erigevano le Piramidi servendosi dell’opera di migliaia di schiavi. Anche per i templi di Selinunte e di Agrigento e di Segesta ci vollero centi
—-
naia di schiavi. Così avveniva a Cartagine, a Roma, in Atene, a Rodi. Ma, qui da noi, ci fu, come altrove, il dispregio della plebe, oltre al massacro, per quel lavoro inaudito degli schiavi. In Sicilia vi furono molti tiranni. I più noti furono quelli di Siracusa e di Agrigento. Ci fu anche un pretore, ladro. Rubava persino le statue auree delle divinità. Si chiamava Verre. I Siciliani lo posero sotto accusa e si fecero difendere da Cicerone, che tu conosci abbastanza bene per gli studi classici che hai compiuto a Oxford.
William annuiva:
– E com’è finita a Verre? Non ricordo bene.
– È andato volontariamente in esilio a Marsiglia. Ma la catena dei fatti e misfatti sarebbe troppo lunga da elencare.
Per ogni sito storico, o classico che dir si voglia, Ilaria aveva argomenti da illustrare ed esporre.
La giornata trascorsa a Palermo fu tra le più piacevoli. Ilaria gli fece visitare la Cattedrale. Ricollegandosi con i fatti e i misfatti, Ilaria passò dalla storia alle leggende storiche. Gli parlò de «I Beati Paoli», dei Baroni di Sicilia, dell’Inquisizione, del rogo di fra Diego La Matina, e della mannaia con cui fu giustiziato Francesco Evangelista Di Blasi. E giù ancora sino alla storia contemporanea. Il banditismo, la mafia, il Governo della Regione Sicilia, la Riforma agraria, gestita dalla mafia dei feudi a salvaguardia degli agrari.
Una tematica, verso la quale un pragmatista anglosassone non si pone altra preoccupazione se non quella della conoscenza generica.
Tutto questo passato della storia – diceva Ilaria – l’angustiava sino a crearsene un problema. Per questa ragione ne era appassionata.
– Capisco. Hai un animo, come dire, delicato, sensibile.
torna sù
A «SOWETO IN SUD AFRICA»
L’inglese aggrottò le fulve sopracciglia. Ilaria proseguì:i
torna sù
ILARIA SPOSA
La traversata dell’Africa, per arrivare al suo estremo lembo, fu considerata come un viaggio di nozze.i
torna sù
CRIS-ILARY
La riflessione su una materia tanto scottante li rendeva incapaci di
